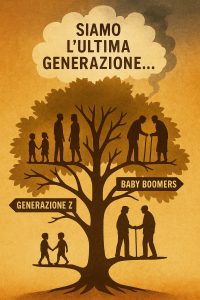 Articolo scritto con l’uso di Intelligenza Artificiale
Articolo scritto con l’uso di Intelligenza Artificiale
Quante volte sentiamo frasi come:
“Siamo l’ultima generazione che può salvare il pianeta.”
“Siamo l’ultima generazione a conoscere la vita senza internet.”
Espressioni ad effetto, spesso utilizzate nei discorsi politici, ambientalisti, motivazionali o nostalgici. Ma c’è un problema serio dietro queste formule: l’uso scorretto del termine generazione.
Nel linguaggio comune, si è diffusa l’idea che “generazione” significhi semplicemente noi oggi, come se tutta la popolazione vivente appartenesse alla stessa categoria temporale, storica e culturale. Questo è concettualmente sbagliato.
In realtà, le generazioni si susseguono nel tempo, si sovrappongono, convivono. Un bambino nato oggi non appartiene alla stessa generazione di chi ha 50 o 70 anni. Dire quindi che “siamo l’ultima generazione che…” presuppone un’uniformità che non esiste.
Le generazioni si distinguono (e si rinnovano)
In demografia, una generazione è definita come l’intervallo medio tra la nascita dei genitori e quella dei figli, solitamente attorno ai 25-30 anni. Ma nel linguaggio socioculturale, le generazioni vengono identificate in cicli ancora più brevi — spesso ogni 7-15 anni — per riflettere cambiamenti nei valori, nei riferimenti storici, nell’accesso alla tecnologia e nei modelli educativi.
Ecco un esempio di come vengono comunemente suddivise:
- Baby Boomers (nati 1946–1964)
- Generazione X (1965–1980)
- Millennial (1981–1996)
- Generazione Z (1997–2012)
- Generazione Alpha (dal 2013 in poi)
Tutte queste generazioni coabitano oggi nel mondo, ognuna con esperienze diverse, con ruoli e responsabilità diverse nella società.
Un problema retorico (e ideologico)
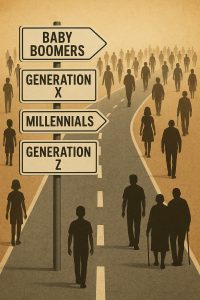 L’espressione “siamo l’ultima generazione che…” è anche una scorciatoia retorica. Serve a:
L’espressione “siamo l’ultima generazione che…” è anche una scorciatoia retorica. Serve a:
- creare allarme o urgenza morale
- evocare un senso di responsabilità collettiva
- o, al contrario, una forma di nostalgia/autocelebrazione (“noi sì che sappiamo com’era la vera vita”)
Ma non è neutra: è un modo di semplificare la realtà e di parlare a nome di tutti, senza distinguere chi sta parlando né a chi ci si rivolge.
In certi casi, può addirittura contribuire a generare tensioni artificiali, come nei discorsi sul “conflitto generazionale” (giovani vs vecchi), spostando l’attenzione dalle vere cause strutturali dei problemi verso colpe immaginarie.
Le parole non sono dettagli secondari: strutturano il pensiero, orientano il modo in cui leggiamo la realtà e parliamo delle responsabilità, dei diritti, delle possibilità. Usare male il termine “generazione” significa semplificare una realtà complessa, impedendo un’analisi lucida dei problemi (ambientali, sociali, politici) che invece richiedono profondità e precisione.




